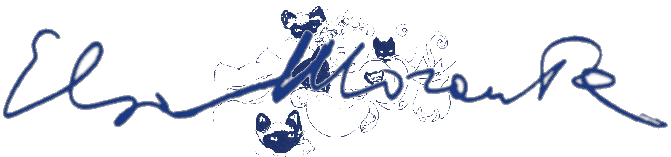
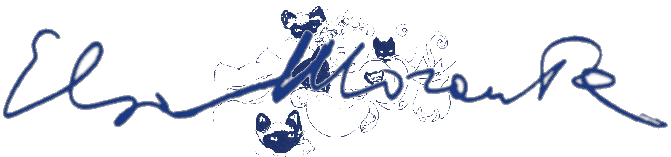
«Questa è la legge: alcuni sudano e si insanguinano i piedi per toccare la Grazia, e diventano rochi per chiamarla, ma inutilmente, perché la Grazia li rifiuta. Altri invece che vivono dimentichi e vaghi come foglie sull'acqua, e non si curano della Grazia e magari la respingono, in ogni momento sono vegliati e baciati da lei, e se la ritrovano al capezzale il giorno della morte.»
C'è una Morante nascosta, tra le pieghe della stampa periodica, effimera, labile, dimenticata. È la Morante che caparbiamente voleva scrivere, da subito, da sempre, che era disposta a rinunciare a tutto, pur di manifestarsi ed esprimersi attraverso la scrittura. È anche la scrittrice che scende in campo, talvolta, per difendere, laddove le individua, la libertà e l'onestà del sentire, le prove di artista che più si avvicinano al suo ideale di arte, quella degli onesti, dei «pazzarielli», dei «Felici Pochi».
1933 - 1941
Elsa Morante pubblicò i suoi primi racconti fin dagli inizi degli anni trenta sul «Corriere dei piccoli», «Il cartoccino dei piccoli» e ancora su «I diritti della scuola» e «Oggi». Sul «Corriere» e sul «Cartoccino» scrisse essenzialmente filastrocche e favole per bambini. I racconti che uscirono invece su «I diritti della scuola» e su «Oggi», regolarmente e prevalentemente nelle due rubriche La pagina dello scolaro e Giardino d'infanzia, erano per lo più rivolti agli adulti e spesso avevano i bambini come protagonisti. I due direttori di «Oggi», Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio, probabilmente proprio pensando alla Morante, concepirono la rubrica Giardino d'infanzia, dove apparvero testi a carattere per lo più narrativo, firmati dalla stessa autrice, mentre altri scritti, pubblicati nella stessa testata con gli pseudonimi Antonio Carrera o Lorenzo Diodati, avevano un taglio più giornalistico e divulgativo. Si trattava di settimanali popolari, come Il «Meridiano di Roma», su cui pure scrisse, grazie all'intervento di Giacomo Debenedetti: videro così la luce L'uomo dagli occhiali; Il giuoco segreto, testo in cui comparve il ritratto che della scrittrice fece Carlo Levi; La nonna, in due puntate; e ancora Via dell'Angelo, Il figlio, Peccato originale.
Più raramente i suoi scritti apparvero in periodici più raffinati e per un pubblico selezionato, quali erano «Il selvaggio», per cui pubblicò il racconto Lo scolaro pallido, o «Prospettive», testata diretta da Curzio Malaparte, che propose invece il testo dal titolo Mille città in una ed il racconto Il confessore.
Era questa un'attività quasi frenetica, intensa, che lasciava intravedere la consuetudine con la tradizione classica, con generi quali l'epica, la favola e, naturalmente, col grande romanzo ottocentesco. Lontana dai modelli contemporanei, la Morante scriveva già con la forza immaginativa ed evocativa, talvolta surreale, che la avrebbe accompagnata successivamente.
Nei brevi racconti, apparsi negli anni per il pubblico più frettoloso ed estemporaneo dei periodici, si delineano già i temi, le tecniche narrative, il progetto edificatorio dei grandi romanzi successivi: il gusto «fabulatorio» della narrazione, tipico forse delle civiltà «primitive» e, perché no, «meridionali»; la atemporalità, la astoricità: tutto reso più incisivo e lapidario dalla brevità del racconto.
1941 -1976
In questo periodo, in seguito anche alle minori urgenze economiche dovute alle mutate condizioni di vita - non ultima delle quali il matrimonio con Moravia - diminuì il lavoro di pubblicista per scomparire quasi del tutto, lasciando spazio alla scrittura più estesa del romanzo, del libro. A segnare il confine tra le due fasi la pubblicazione, nel 1941, della prima raccolta di racconti, Il gioco segreto, con Garzanti e, nel 1942, del «romanzo-fiaba» Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina, con Einaudi. Qui la narrazione, condotta con una leggerezza ed una freschezza che poi sarà difficile ritrovare, indica già i motivi che saranno sviluppati nelle opere successive. In primo luogo l'attenzione, se non l'attrazione, per gli animi semplici, lontani da qualsiasi contaminazione con il «potere», capaci di sentire fiduciosamente la realtà, non senza tuttavia percepirne l'aspetto doloroso: «Le cose che più odia sono le dittature, il moralismo austero e la musica leggera. Al mondo, più di tutto ama i bambini, il mare e i gatti».
«Un albero, un animale, un bambino sono sempre belli. Quello che è naturale è sempre bello».
«Voi non potete neppure immaginare quanto siano veloci i sogni. Essi vi fanno fare meravigliosi viaggi come niente fosse, in un momento... L'inventore dei sogni ... non si dà le arie affatto. Non si sa neppure chi sia. Forse il buon Dio, o forse gli angeli, o forse i poeti. Non si sa».
Solo negli anni '50-'51 si ebbe un breve ritorno all'attività giornalistica con la pubblicazione di recensioni cinematografiche per la Rai nella rubrica settimanale «Cronache del cinema» e con la collaborazione a «Il Mondo». Per il foglio diretto da Mario Pannunzio scrisse nella rubrica Rosso e bianco sette articoli poi pubblicati in Pro o contro la bomba atomica e altri scritti, nonché un paio di interventi nella sezione Lettere scarlatte, il primo nel maggio '50 per prendere posizione a favore del film di Visconti La terra trema, ed il secondo, datato 1 dicembre 1951, per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle pressioni censorie della RAI, rendendo pubbliche le proprie dimissioni dalle già citate «Cronache del cinema».
Nel 1953 viene pubblicato su «Botteghe oscure» Lo scialle Andaluso, che poi fornirà il titolo alla seconda raccolta di racconti del 1963.
In ogni caso quello del racconto pubblicato su fogli periodici è un lavoro ormai parallelo, più episodico: la caparbietà delle origini ha dato i suoi frutti, anche se la fama e la notorietà, l'appartenenza al Gotha dell'intellighentia italiana non possono estirpare il contrasto inevitabile tra «le ragioni umane e le ragioni misteriose della realtà».
«il...vero tema [dei miei racconti] è, ancora una volta, il solito tema - unico , per quanto svariato - di tutti i miei ... romanzi e storie: e cioè (per dirlo in modo sommario) il difficile rapporto fra le ragioni umane e le ragioni misteriose della realtà.»
Sono ormai giunti gli anni della notorietà, in cui, dopo Menzogna e sortilegio, e poi con L'isola di Arturo, i premi e i riconoscimenti sanciscono lo status di scrittore. Alla produzione talvolta forsennata di racconti si é ormai sostituto l'adagio della grande architettura del romanzo. Ma l'istanza che muove la scrittura, la tensione che guida il filo della narrazione rimangono le stesse. La progettazione, la gestazione sono certo più lunghe, ma il sentire non muta.
«Romanzo sarebbe ogni opera poetica, nella quale l'autore - attraverso la narrazione inventata di vicende esemplari (da lui scelte come pretesto, o simbolo delle «relazioni» umane nel mondo) - dà intera una propria immagine dell'universo reale (e cioè dell'uomo, nella sua realtà) ... L'interezza, poi, dell'immagine rappresentata, distingue il romanzo dal racconto. Il racconto, difatti, rappresenta un «momento» di realtà, mentre il romanzo rappresenta una realtà (da questo non si desume, tuttavia, una superiorità poetica del romanzo sul racconto! Non si tratta di qualità superiore o inferiore, ma di un differente rapporto con l'universo).»
E nello sfondo una stanza, come diritto e «necessità», luogo dove la riflessione e la creazione trovano spazio, dove la diversità ottiene asilo, dove gli inestetismi del vivere si sublimano nella grazia della scrittura.