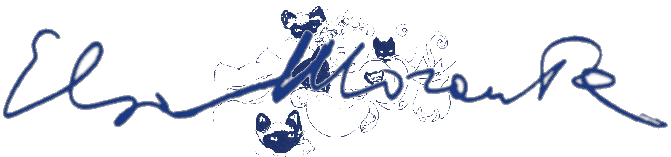
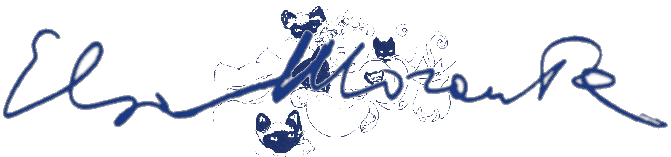
Il romanzo
Il romanzo è la narrazione, anzi la ricostruzione, di un triste episodio riportato da un giornale romano nel giugno del 1947: una madre e il suo figlioletto morto vengono ritrovati, in compagnia di un cane pastore maremmano, in un appartamento del quartiere Testaccio. Da questo finale tragico la Morante ripercorre gli antefatti, che si svolgono nel corso di sei anni. La storia che vede come protagonista la vicenda individuale del piccolo Useppe in compagnia della madre Ida, si svolge, però, in un continuo gioco di rimandi e di scambi con la storia collettiva. Lo stile annalistico è, infatti, una delle principali caratteristiche dell'opera, ed è costruito allo scopo di mostrare che la Storia ricapitola, anzi travolge, la vicenda dei singoli individui.
Pubblicato da Einaudi nel 1974, La Storia deve aver visto la luce nella mente della scrittrice già negli anni Sessanta. Su due carte del manoscritto la Morante accenna, infatti, a una stesura precedente, risalente almeno al 1962. Il manoscritto di Senza i conforti della religione contiene inoltre molti elementi che anticipano gli argomenti sviluppati ne La Storia: possiamo dunque pensare che non vi fu una vera e propria redazione della Storia risalente agli anni Sessanta, ma un testo preliminare abbozzato nei manoscritti di Senza i conforti della religione. Ancora, l'aspetto del manoscritto di Senza i conforti della religione, completamente smembrato, fa supporre che la Morante abbia smontato quel testo e lo abbia parzialmente riutilizzato per scrivere La Storia (e poi, verosimilmente, anche Aracoeli).
Il romanzo, pubblicato nel 1974, regalò alla scrittrice un enorme successo di pubblico (le tirature de La Storia furono seicentomila) e divenne, almeno agli occhi della critica più feroce, un'opera nazional-popolare. Lo scopo dichiarato dalla Morante era quello di parlare a tutti, e di essere "dentro" la Storia.
Il rapporto osmotico tra storia individuale a collettiva è testimoniato non solo dallo stile annalistico, ma anche dalle oscillazioni nella scelta del titolo, che, nei manoscritti, è prima T.U.S. (acronimo di "Tutto uno scherzo", il canto dei canarini ma anche il modo di intendere la Storia da parte di Useppe), poi Il grande male (l'epilessia) infine La Storia con la maiuscola, come eterna vicenda di violenza e sopraffazione.
Il manoscritto
Il complesso dei manoscritti de La Storia è così costituito: quattro quaderni formato album (più uno di prove annullate) della stessa tipologia di quelli del Mondo salvato dai ragazzini e di Senza i conforti della religione; tredici quaderni di grande formato con legatura di cartone rigido di colore azzurro; due quaderni di tipo scolastico; una cartella con intestazione autografa "ultime bozze", contenente in realtà solo le correzioni; una cartella di scarti e rifacimenti; una cartella contente il dattiloscritto.
Ciò che colpisce, in questi manoscritti, è il rigore metodologico costantemente osservato dalla scrittrice. Proprio in virtù di tale rigore le modalità di scrittura, già istituite negli altri romanzi, sono meglio definite. Ogni parte del manoscritto ha infatti una sua funzione precisa.
I piatti di coperta ospitano le citazioni, i riferimenti puramente letterari, i precedenti emotivi così come gli elenchi di parole. Trascrizioni di poesie di Dylan Thomas, César Vallejo, Miguel Hernandez compaiono ad esempio sul piatto anteriore, altre di Alce Nero su quello posteriore.
È come se, all'inizio e alla fine dei quaderni, la Morante predisponesse un "serbatoio", una serie di riferimenti da cui partire per dare significato al romanzo. Un ruolo analogo hanno gli elenchi di parole, che sono la preparazione di un lessico di appartenenza, di una lista "controllata" di termini, di un vocabolario privilegiato cui attingere in caso di necessità, tant'è che i termini più amati dalla scrittrice sono sottolineati. Sembra dunque che la Morante assegni ai piatti questa funzione, per poter tornare facilmente, durante il lavoro di scrittura, ai suoi punti di riferimento.
Il verso delle carte è utilizzato con altri scopi: serve a inserire correzioni, rifacimenti, integrazioni, utilizzando segni di richiamo come l'asterisco, il cerchio col puntino al centro, la stella giudaica. Ancora, il verso viene utilizzato per apporre riflessioni sul carattere di un personaggio, il suo nome, il suo abbigliamento o per procedere a una rapida ricapitolazione sulla successione degli eventi.
Nel caso de La Storia il verso presenta una caratteristica in più: l'enorme impianto di documentazione storica, indispensabile per la redazione del romanzo. Sappiamo bene che la scrittrice si documentò in maniera a dir poco capillare. La Morante stessa indica i suoi principali testi di riferimento nella nota all'edizione de La Storia, ma la sua biblioteca rivela un numero di letture ben più ampio.
Sul verso sono annotate tutte le fonti a cui l'Autrice ricorre per la narrazione, con un'attenzione, quasi ossessiva, per l'esattezza dei dati. L'ampio ventaglio delle sue letture va da G. De Benedetti e R. De Felice sulla storia degli ebrei ai tempi del fascismo, ai volumi di N. Revelli per i fatti della campagna di Russia, a E. Piscitelli sui dati della resistenza romana.
Per l'esposizione delle leggi razziali, la Morante fa ricorso a fonti sicure. Ampia è inoltre la documentazione fotografica utilizzata. Questa immensa opera di documentazione non si limita solo alle fonti bibliografiche, ma raccoglie anche notizie di altro tipo: per la descrizione dei percorsi seguiti da Ida in città la scrittrice tiene a portata di mano una carta dei quartieri Ghetto e Testaccio e all'occasione disegna da sé uno schizzo sommario di questo percorso. La cura delle fonti si fa scrupolosa addirittura sulla natura dei canarini, per i quali la Morante trova non solo un riferimento letterario, una poesia di Saba, ma anche la descrizione scientifica della differenza tra canarino e lucherino. Stesso discorso vale anche per il dialetto romanesco, per il quale la Morante redige non solo elenchi di parole specifici, ma anche simulazione di colloqui sul verso delle carte.
Le edizioni
La prima edizione de La Storia viene pubblicata da Einaudi nel giugno 1974 nella colana «Gli Struzzi» in edizione economica al prezzo politico di duemila lire. In un primo momento la Morante pensa di mettere in copertina la celebre foto del Miliziano caduto di Robert Capa, immagine simbolo di chi sacrifica la propria vita nella lotta per la libertà, ma poi decide per un'altra fotografia di Capa, un uomo qualunque caduto di faccia, di cui non conosceremo mai il volto.Le stanze di Elsa - La storia