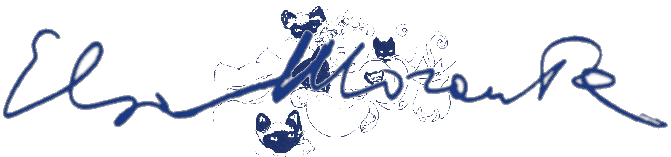
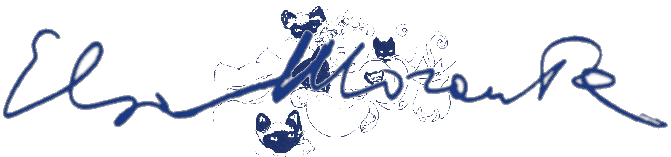
«Elsa Morante esige dal proprio critico, o dal proprio lettore, un rapporto diretto, frontale, desidera essere riconosciuta subito in viso, da sguardi che non si attardino a spiarla attraverso lenti secondarie» (Cesare Garboli, Due presentazioni, «Palatina», apr.-set. 1963). Infatti è attraverso i libri scritti da Elsa, quelli pubblicati e quelli no; le letture più amate; i suoi manoscritti: veri e propri palinsesti; le sue carte più minute; le sue case per scrivere e persino gli oggetti e i gatti dei quali si circondava, che la mostra ha tentato di restituire il carattere più autentico e originale di un narrare che ha consentito a molta critica di affermare di trovarsi davanti al più grande scrittore italiano del ventesimo secolo. Un narrare che dipanava le sue trame e riaffermava la validità del romanzo in tempi nei quali si dibatteva sulla sorte di questa forma letteraria.
Malgrado i premi letterari vinti e l'apprezzamento di larga parte della critica, Elsa Morante non ebbe mai, e il suo carattere ne porta parte di responsabilità, un rapporto piano con la critica: era scrittrice che poteva essere solo o amata o disprezzata; le mezze misure non si addicevano a lei. Ma quelle «lenti secondarie», così spesse in tempi di fortissime contrapposizioni ideologiche, facevano leggere i romanzi di Elsa come attraverso atmosfere non limpide. Anche chi (è il caso di Lukács) contribuì, dando alla scrittura morantiana una chiave di lettura «di sinistra», alla notorietà dei suoi romanzi, aveva letture distorcenti; ed ecco che il «realismo magico» di Menzogna e sortilegio divenne «realismo critico». Lukács attendeva Elsa a un ulteriore passo: da un «per sé» individualista a un «per noi». Allora sarebbe stata la consacrazione definitiva: senza se e senza ma. Quel passo, forse, Elsa lo fece, calandosi nell'umanità dolente de La Storia, e i lettori seppero coglierlo come da sempre l'hanno colto in Guerra e pace. finalmente ad Elsa arrise anche il grande successo di pubblico. Ma la sua filosofia della storia non prevedeva palingenesi, né terrene né ultraterrene, e la critica si divise ancora una volta. Ne La storia il successo non arride mai agli umili: né quello individuale né quello collettivo; ma sbaglierebbe chi volesse cercare in ciò che per la Morante è una semplice constatazione, la parvenza di un giudizio, di una sentenza weberianamente intesa; né è possibile rintracciarvi un agente esterno sulla scorta della manzoniana Provvidenza, l'unico agente è La Storia stessa che conduce gli umili quasi sempre al naufragio così come fece naufragio l'altra Provvidenza: quella verghiana.
Soltanto dopo la sua morte, forse, Elsa Morante e la sua scrittura sono state affrontate con quel necessario e ossimorico distacco appassionato che solo consente scavi approfonditi e accurate ricognizioni. Fu a partire da quel 1985 infatti che la critica, un po' sulla spinta di anniversari e commemorazioni, un po' per un sempre più marcato prosciugarsi di quelle pulsioni che costringevano, quale che fosse il campo, a schieramenti militanti, adottò anche con Elsa un metodo di lavoro più scientifico e sistematico e così, anche per il fondamentale apporto dato dalle facoltà di italianistica sparse per i cinque continenti, la scrittura di Elsa Morante è stata finalmente studiata per quello che voleva essere e non più per quello che avrebbe potuto o dovuto essere: e finalmente i caratteri originali e la forte carica innovativa del narrare morantiano non sono più stati in discussione.
Le stanze di Elsa - Dalla stampa periodica