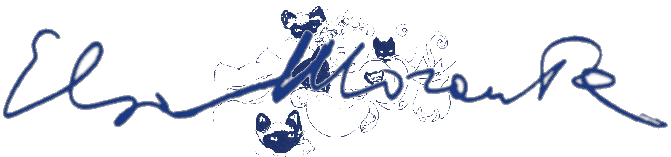
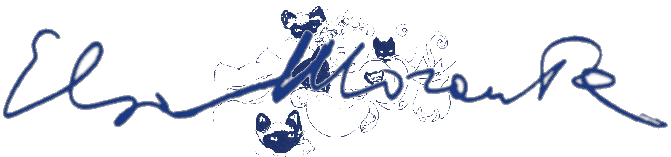
Introduzione
Quando comincia un romanzo si direbbe che la Morante ci stia raccontando non più della storia di un gatto, di un mobile di casa, tanto è vero che nascono le sue storie, da prospettive familiari, domestiche, addirittura anguste: da un corridoio, da un cortile, da una cucina, da quei luoghi dove noi abitiamo distratti, e dove la vita si ripete da sempre, e sembra durarvi perpetua, come se il tempo, frusciando tra gli oggetti a noi noti, tra cento cose consunte, trascorrendo di stanza in stanza, trovasse il modo di farci sapere che in quei luoghi egli non fugge ma vi dimora" (Cesare Garboli)
La necessità di appartarsi, di disporre di un luogo dove lavorare e scrivere in tranquillità o addirittura in isolamento fu un esigenza più volte espressa da Elsa Morante, e ricercata, ogni volta che le fu possibile: per scrivere aveva bisogno di isolarsi, di negarsi al resto del mondo, di dedicarsi unicamente al suo lavoro, anche se durava anni, con dedizione quotidiana.
Le "stanze" dove Elsa Morante visse e lavorò nel corso della sua vita furono il laboratorio dove ella elaborò un suo personale modo di aprirsi alla scrittura: in questo senso esse vanno considerate luoghi del vissuto, reali e definite entità spaziali, in cui Elsa realizza la composizione dei romanzi, ma anche e soprattutto esse rappresentano la metafora di una condizione interiore, di una ricerca incessante della chiave per sedimentare il vissuto e del registro per raccontarlo.
"Sono più autobiografici i romanzi di qualsiasi altra cosa si possa raccontare di sé", spiega a Enzo Siciliano che la intervista nel 1972, "Perché nei romanzi avviene come nei sogni: una magica trasposizione della nostra vita, forse anche più significativa della vita stessa, perché arricchita dalla forza dell'immaginazione. La mia vita sta in Menzogna e sortilegio, nell'isola di Arturo...".
L'enorme mole di attività scrittoria non è espressa soltanto dall'estensione quantitativa dei suoi manoscritti (quaranta quaderni per Menzogna e sortilegio, sedici per L'isola di Arturo, diciotto per La Storia, senza parlare delle carte sciolte, degli appunti, del materiale che precede e segue la stesura manoscritta) ma dall'ampiezza e dalla meticolosa precisione con cui vengono costruite le motivazioni psicologiche, le movenze caratteriali, le condizioni esistenziali dei personaggi, anche secondari.
Non tutto finirà sulla pagina stampata, molto viene cassato durante le revisioni, con un frego verticale che attraversa il foglio, la cancellatura delle parole o più spesso tagliando le pagine e riscrivendo da capo.
La psicologia dei personaggi è costruita minuziosamente, perché nel romanzo possano vivere ed agire secondo una coerenza che deve rispettare il loro carattere, il loro "vissuto", fosse anche un vissuto che al lettore non è necessario raccontare.
"Non bisogna dire ogni cosa!". La preoccupazione ricorre spesso e si ritrova espressa variamente tra le carte manoscritte di Elsa Morante. Frequentissime sono le indicazioni di questo genere che si possono leggere tra le note scritte in margine al testo, sul verso bianco dei quaderni. Si tratta di un lavoro incessante che la accompagnerà lungo tutto l'arco delle sue composizioni narrative. Le revisioni del testo hanno tra l'altro proprio il compito di asciugare, contrarre, riordinare.
Ma questa preoccupazione rappresenta solo il bilanciamento alla necessità insopprimibile, che è parte integrante del suo stesso metodo di lavoro, che è dietro alla enorme produzione manoscritta: la necessità di non tralasciare niente, di curare ogni dettaglio, di controllare ogni passaggio, salvo poi nasconderlo o alleggerirlo.
I quaderni
I manoscritti di un opera ne rappresentano l'antefatto, raccontano il processo e rendono manifesto il metodo con cui lo si è realizzato.
Un testo è sempre parte di una materialità, quella dell'oggetto che lo trasmette, e il metodo di scrittura e il modo di scrivere sono strettamente legati al supporto adoperato.
Elsa Morante ha scritto sempre a mano la prima stesura dei suoi romanzi utilizzando quaderni scolastici, quelli con la copertina nera e il taglio rosso, oppure grandi quaderni simili a registri, o album da disegno, sui quali amava scrivere nel senso longitudinale della pagina, dove la sua scrittura minuta e regolare si distendeva ariosa: il testo si trasferiva poi - spesso profondamente modificato - sul dattiloscritto.
Nel corso degli anni i quaderni variano per tipologia e sempre legano le loro caratteristiche esterne al romanzo per il quale sono stati adoperati. Tanto questo legame tra l'opera e il manufatto su cui si sviluppa è rilevante nell'archivio morantiano che in linea generale sarebbe possibile non solo riconoscere il manoscritto di un opera, senza nemmeno sfogliarne le pagine, solo dall'aspetto esteriore del quaderno, ma il manufatto stesso diventa strumento prezioso per interpretare le fasi di scrittura, precisare le datazioni, individuare gli innesti di un romanzo sull'altro.
Il testo si sviluppa solo sul recto delle pagine, mentre il verso, lasciato bianco viene utilizzato per revisioni, correzioni, inserimenti successivi, note. Le pagine dei quaderni sono sempre numerate dalla scrittrice, solo sul recto, senza soluzione di continuità tra un quaderno e l'altro e così la successione dei quaderni.
Ci fu sicuramente anche nelle scelte frequenti di quaderni di tipo diverso una ricerca che avvicinasse il supporto scrittorio il più possibile alla esigenza della scrittrice: ad esempio il passaggio a grandi formati, che una volta acquisiti non furono mai abbandonati, consentiva di avere più spazio, nel verso della pagina, per gli interventi paratestuali, e allo stesso tempo, liberava un andamento più arioso della scrittura che si distendeva nella grande pagina, ampliato dall'uso longitudinale del quaderno; mentre l'introduzione di album a fogli mobili o con il taglio tratteggiato, le permisero ad un certo momento di introdurre il metodo di togliere o inserire direttamente le pagine in una sorta di "taglia e incolla" ante litteram.
La revisione del testo di cui il manoscritto mostra sempre numerose tracce - anche se raramente distruttive - non necessariamente deve intendersi come un operazione a posteriori e successiva alla stesura del testo.
A Paolo Monelli Elsa spiega: "Scrivo sempre a mano, e procedo molto lentamente, e solo quando il periodo mi è venuto ben chiuso e calettato e le parole sono quelle che devono essere e non altre suggerite dalla fretta, solo allora passo ad altro periodo. E lo stesso faccio con i capitoli".
Il manoscritto morantiano si presenta sempre - anche se con diverse evidenze, - maggiormente in Menzogna e sortilegio che negli altri romanzi - come una sorta di ipertesto - il luogo dove convergono e si leggono simultaneamente i vari elementi di cui il testo si compone e da cui è generato: la memoria, la cronaca, la tradizione letteraria, la ricerca linguistica.
Tutto questo è la testimonianza di come la scrittura sia per Elsa Morante una esperienza totalizzante, che coincide, nel momento in cui scrive, con la vita stessa, dove va a confluire tutto il suo vissuto.
Le stanze di Elsa - Introduzione